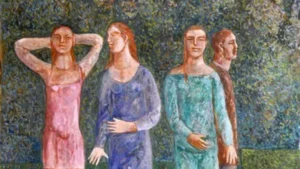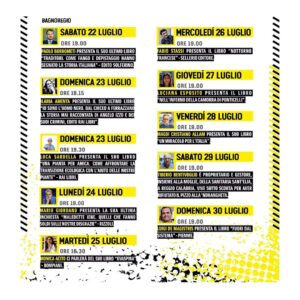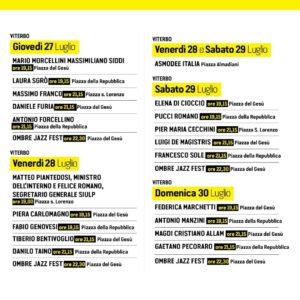Otto settembre 1943, la seconda guerra mondiale entra in una fase di massima criticità: l’Italia, dopo la caduta del fascismo, si dissocia dall’Asse Roma-Berlino e sottoscrive un armistizio separato con gli alleati anglo-americani. Il regio esercito si dissolve; tra i pochi rimasti a presidiare la continuità istituzionale sono i carabinieri.
I tedeschi, furibondi, danno luogo a una durissima repressione contro quelli che considerano i “traditori italiani”; il clima che si respira in quei duri momenti si percepisce tutto nel lugubre motto “per ogni tedesco dieci italiani”; anche per il fatto che i dieci italiani venivano rastrellati a caso.
Pochi giorni dopo l’otto, un reparto di paracadutisti tedeschi, acquartierati nella zona di Torrimpietra, frazione di Fiumicino, non lontana da Roma, ispezionano alcune munizioni abbandonate; probabilmente utilizzate per la pesca di frodo. Forse a causa di un errore provocano l’esplosione di una bomba a mano; due militari restano uccisi, altri due feriti.
Il sottufficiale comandante del reparto qualifica il fatto come un attentato e ne attribuisce la responsabilità ad attentatori locali; si rivolge allora ai carabinieri di Torrimpietra chiedendo collaborazione; in assenza del maresciallo comandante si rivolgono al giovane vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920, minacciando una sanguinosa rappresaglia qualora non venissero individuati gli attentatori. D’Acquisto svolge le prime indagini e riscontra presto che l’esplosione è conseguenza di un caso fortuito e di questo cerca di convincere il comandante tedesco; ma questi rimane irremovibile sulla tesi dell’attentato. Non soltanto, il sottufficiale tedesco minaccia di attuare la tristemente celebre “ordinanza Kesserling” (dal nome del feldmaresciallo Albert Konrad Kesserling, responsabile dell’intero settore sud del teatro di guerra), in sostanza la disposizione che prevede i massacri di civili.
Il 23 settembre di 80 anni fa i tedeschi rastrellano così 22 cittadini scelti a caso, tra cui un 13-enne; un 23° sarà aggiunto in seguito. Nuovamente interrogato, D’Acquisto conferma il risultato delle sue indagini sull’origine accidentale dell’esplosione; per questo sarà sottoposto a un pestaggio mantenendo tuttavia un comportamento calmo e dignitoso. Verificata l’impossibilità di scoprire gli inesistenti colpevoli il comandante dà gli ordini per le operazioni di fucilazione; operazioni che comprendevano lo scavo, da parte degli accusati innocenti, di una grande fossa comune.
È in quel momento che Salvo D’Acquisto compie il suo gesto eroico auto-accusandosi, davanti all’attonito comandante tedesco, di essere lui l’autore materiale dell’attentato.
Questa la testimonianza di uno dei presenti: “All’ultimo momento, però, contro ogni nostra aspettativa, fummo tutti rilasciati eccetto il vicebrigadiere D’Acquisto. […] Ci eravamo già rassegnati al nostro destino, quando il sottufficiale parlamentò con un ufficiale tedesco a mezzo dell’interprete. Cosa disse il D’Acquisto all’ufficiale in parola non c’è dato di conoscere. Sta di fatto che dopo poco fummo tutti rilasciati: io fui l’ultimo ad allontanarmi da detta località.”
Ad essere fucilato sarà soltanto il carabiniere-eroe Salvo D’Acquisto; un testimone riferirà più tardi di aver udito il grido “viva l’Italia”.
Per alcuni giorni il corpo rimane nella fossa, poi due donne, Wanda Baglioni e Clara Lambertoni, provvedono a trasportare il corpo nel cimitero locale.
Nel 1947 la madre ottiene l’autorizzazione alla traslazione delle spoglie a Napoli; nel 1986 vengono nuovamente traslate dapprima in una camera ardente presso il Comando della Legione Carabinieri Campania e poi al Sacrario Militare di Posillipo, dove riposa tuttora con gli onori attribuiti a uno dei massimi eroi dell’Italia contemporanea.
Nell’80° del sacrificio l’Arma dei Carabinieri e gli italiani ricordano con commozione e riconoscenza chi ha dato la vita per la salvezza delle persone che il dovere aveva messo sotto la sua protezione.
Al ricordo e alle onoranze si aggiunge quella di papa Francesco che ha dedicato un’udienza speciale in piazza S. Pietro ai rappresentanti dell’Arma, cui ha rivolto queste parole: «Vi ringrazio per essere venuti. È bello incontrarvi. Oggi siamo qui nel ricordo del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, Servo di Dio ed Eroe della Patria».
Per Salvo è attualmente in corso il procedimento di beatificazione.
-
SEZIONI
-
I MIEI ULTIMI ARTICOLI
-
- INCONTRO FRA IL VESCOVO DI VITERBO E I GIORNALISTI DELLA STAMPA LOCALE

- 13 DICEMBRE 1466: MUORE DONATELLO, MAESTRO DEL RINASCIMENTO FIORENTINO
- In memoria di Emily Dickinson

- 7 DICEMBRE 1598: NASCE LO SCULTORE GIAN LORENZO BERNINI, IL POETA DELLA FORMA

- 4 DICEMBRE 1882: MUORE UN GRANDE VITERBESE ONORARIO IL GENIALE ARCHITETTO VIRGINIO VESPIGNANI